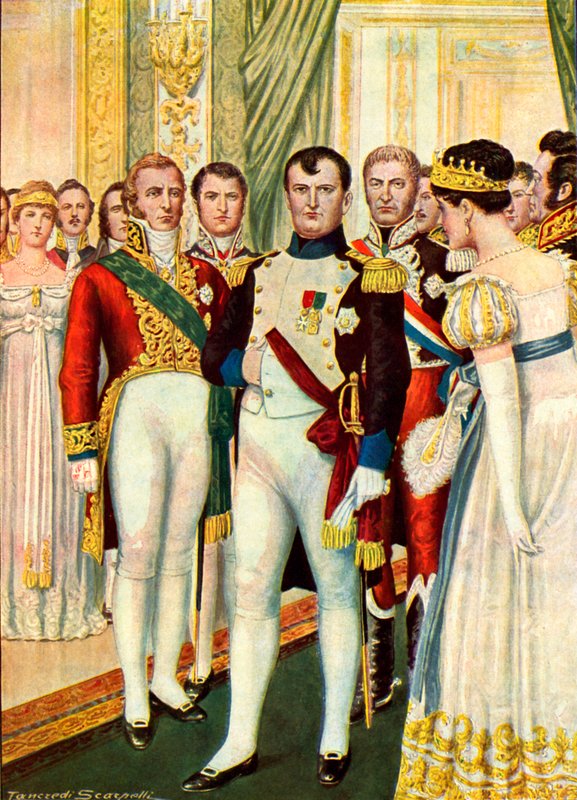Il 7 agosto 1830, in una Parigi ancora scossa dai disordini di luglio, la Camera dei Deputati presenta ufficialmente al Duca d'Orléans, Luigi Filippo di Borbone, l’atto di nomina a Re dei Francesi e la nuova Carta costituzionale del 1830. Si tratta di un momento fondativo della cosiddetta Monarchia di Luglio, un esperimento di potere monarchico costituzionale e parlamentare, nato dalle barricate, ma indirizzato — almeno nelle intenzioni — verso una stabilizzazione liberale e moderata del Paese.
Eppure, in quell’austera cerimonia al Palazzo Reale, un’ombra ingombrante aleggia nella memoria collettiva e nel dibattito politico: quella di Napoleone Bonaparte. Scomparso da quasi un decennio, ma mai dimenticato, il ricordo dell’Imperatore continua a influenzare, condizionare e inquietare le istituzioni della nuova Francia post-rivoluzionaria.
Dopo la cacciata di Carlo X, sovrano reazionario e ultimo rappresentante della Restaurazione borbonica, la Francia è di nuovo in cerca di un equilibrio. Il popolo ha dimostrato la sua forza, ma i protagonisti del cambiamento non sono né i giacobini né i bonapartisti: sono i liberali moderati, espressione della nuova borghesia cittadina, che scelgono Luigi Filippo come “Re dei Francesi”, e non “di Francia”, secondo una formula che già rimandava alla breve stagione monarchico-costituzionale del 1791.
Questo passaggio, apparentemente tecnico, è in realtà profondamente simbolico: il potere non deriva più da un diritto dinastico, ma da una legittimazione nazionale. Tuttavia, a differenza della radicalità della Rivoluzione francese o del centralismo imperiale napoleonico, la Monarchia di Luglio si propone come una via di mezzo, una sintesi tra autorità e libertà, tra ordine e progresso.
Ma proprio in questo compromesso si avverte la mancanza — o la forza rimosso — del grande assente: Napoleone Bonaparte. Nonostante la sua morte a Sant’Elena nel 1821, il mito imperiale è vivo, potentissimo, soprattutto tra le classi popolari e tra i veterani dell’esercito. Mentre la nuova monarchia si insedia a suon di carte costituzionali e formule liberali, in molti, nei caffè di Parigi come nei sobborghi delle province, si chiedono se l’aquila imperiale potrà mai tornare a volare.
I bonapartisti, sebbene marginalizzati politicamente, conservano un forte ascendente emotivo. La Monarchia di Luglio sa di dover governare anche contro questo fantasma, cercando di neutralizzarlo con una narrazione di stabilità e prosperità borghese. Ma l’eco del passato imperiale non si spegne: negli anni successivi, sarà il giovane Luigi Napoleone Bonaparte, nipote dell’Imperatore, a capitalizzare quel sentimento diffuso, arrivando all’Eliseo nel 1848 e proclamando il Secondo Impero nel 1852.
La rivoluzione del 1830 non è stata un’insurrezione totale come quella del 1789. È stata, piuttosto, una correzione di rotta, un rifiuto della Restaurazione senza abbracciare l’ideale repubblicano o bonapartista. Ma nella solenne cerimonia del 7 agosto, con Luigi Filippo che accetta la Corona senza abiti regali, in un gesto quasi dimesso, si percepisce chiaramente il peso della storia recente.
I deputati liberali non vogliono un re che governa per diritto di nascita, ma nemmeno un altro Napoleone che sciolga il Parlamento con un colpo di Stato. Cercano una Francia che possa finalmente conciliarsi con se stessa, che smetta di oscillare tra trono e ghigliottina, tra restaurazione e rivoluzione.
Ma la presenza simbolica di Napoleone — con la sua promessa di merito, di ordine, di gloria — resta sullo sfondo. Come a ricordare che ogni nuovo ordine, in Francia, deve inevitabilmente fare i conti con l’Impero, con ciò che ha significato, e con ciò che potrebbe, un giorno, significare ancora.
E così, mentre Luigi Filippo firma la Carta del 1830, in molti già si domandano se la monarchia costituzionale saprà resistere all’onda lunga dell’eredità napoleonica. Una domanda che troverà risposta meno di vent’anni dopo, quando sarà un altro Bonaparte — Luigi Napoleone — a riprendersi la scena.