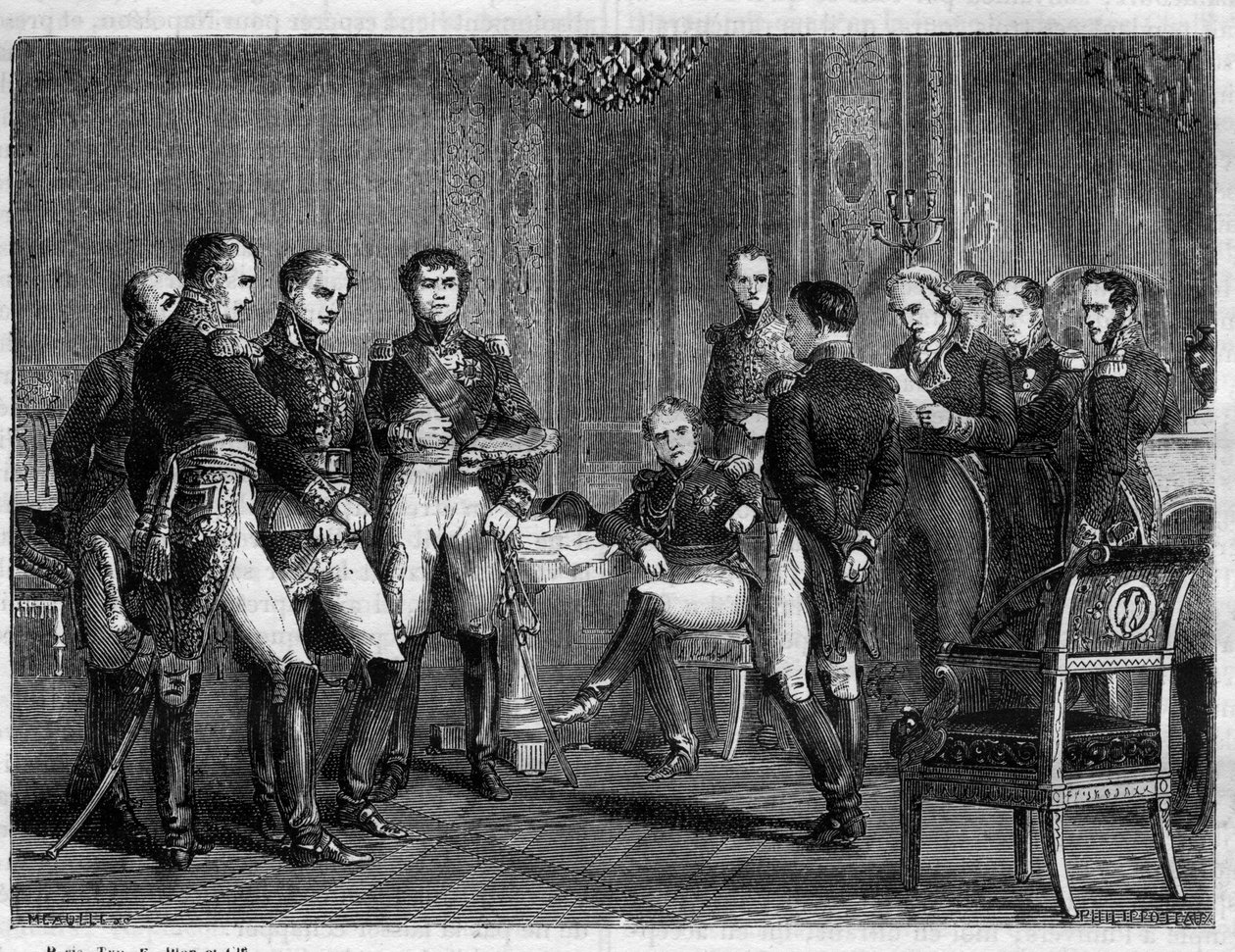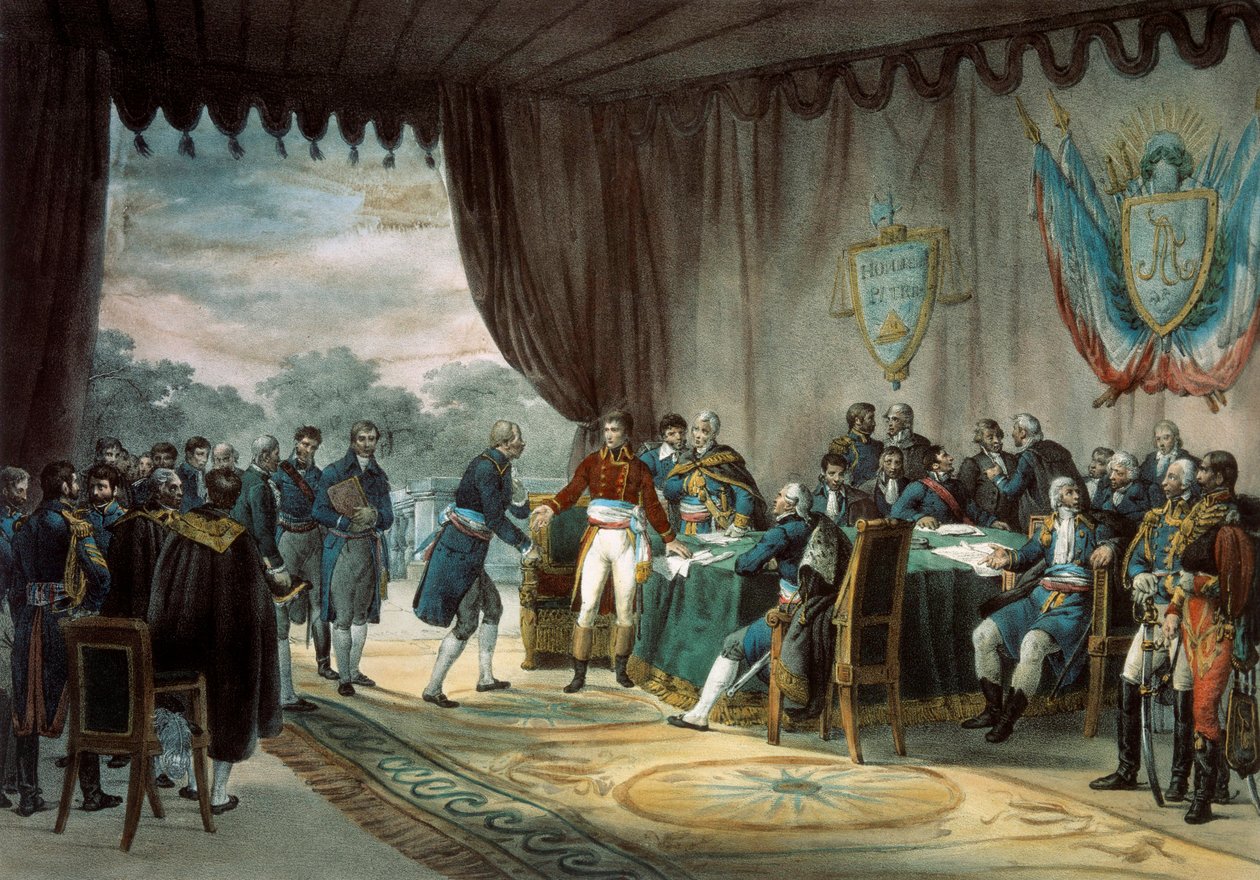Parigi, 26 dicembre 1799 — Nella solenne cornice del Palazzo
del Lussemburgo, oggi cuore nevralgico del nuovo governo francese, si
è consumato un evento destinato a segnare un profondo spartiacque
nella storia della Repubblica. I tre consoli, Bonaparte, Cambacérès
e Lebrun, hanno ricevuto il giuramento dei presidenti delle nuove
sezioni governative, suggellando ufficialmente l’assetto politico
emerso dal colpo di Stato del 18 brumaio (9 novembre 1799). Un
momento denso di significato istituzionale, ma anche carico di
simbolismo, che rappresenta il passaggio definitivo dalla caotica
stagione rivoluzionaria a una nuova forma di ordine repubblicano,
centralizzato e tecnocratico.
Il Consolato nasce dalle ceneri del Direttorio, il regime che, tra
il 1795 e il 1799, tentò invano di mantenere la stabilità in un
Paese dilaniato da guerre, carestie e instabilità politica. Il colpo
di Stato guidato dal generale Napoleone Bonaparte — all'epoca
ancora acclamato come "salvatore della patria" per le sue
campagne in Italia ed Egitto — ha portato all’instaurazione di
una nuova Costituzione (quella dell’anno VIII), la quale ha
trasferito il potere esecutivo a tre consoli: il Primo Console,
Napoleone stesso, figura dominante del triumvirato; il secondo
console, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, giurista raffinato e
moderato repubblicano; e il terzo console, Charles-François Lebrun,
intellettuale e amministratore esperto, già collaboratore di
Malesherbes e sostenitore delle riforme tardo-monarchiche.
Il giuramento dei presidenti delle sezioni amministrative —
Consiglio di Stato, Tribunat, Corpo Legislativo e Senato conservatore
— rappresenta dunque l’atto formale di adesione delle nuove
istituzioni alla guida del Consolato, ponendo fine alle ambiguità e
alle resistenze residue nei ranghi politici ancora legati al passato
giacobino o termidoriano.
La cerimonia si è svolta in modo ordinato, severo, senza la pompa
monarchica ma nemmeno con l’ostentata frugalità rivoluzionaria.
Alle ore dieci del mattino, i tre consoli sono apparsi nella grande
sala del Consiglio di Stato, vestiti in abiti cerimoniali sobri ma
eleganti. Bonaparte, come sempre, ha attirato su di sé ogni sguardo.
Il volto severo, quasi marmoreo, non ha mai lasciato trapelare
emozione; l’unico movimento frequente era quello delle mani, che
serrava dietro la schiena con la tipica impazienza del comandante
abituato a dare ordini più che a riceverli.
Il primo a prestare giuramento è stato Pierre Daunou, uno dei
redattori della nuova Costituzione, ora incaricato di presiedere il
Tribunato. La formula è stata pronunciata con voce ferma: “Giuro
fedeltà alla Repubblica, obbedienza alla Costituzione e rispetto per
l’autorità dei Consoli.” A seguire, ciascun presidente ha
replicato le parole, ponendo la mano destra sul testo della
Costituzione dell’anno VIII.
Il silenzio nella sala era assoluto. Ogni parola, ogni
inflessione, risuonava come un impegno irrevocabile verso il futuro
della nazione. La retorica rivoluzionaria, un tempo intrisa di
fervore ideologico, ha lasciato il posto a un linguaggio giuridico,
amministrativo, quasi tecnico. Non più “virtù” e “terrore”,
ma “ordine”, “efficienza”, “stabilità”. La rivoluzione,
pare, ha finalmente trovato un linguaggio che le consenta di
sopravvivere alla propria foga distruttiva.
Sebbene formalmente alla pari con Cambacérès e Lebrun, è chiaro
a tutti che Bonaparte sia già molto più che un Primo Console. I
documenti sono redatti secondo la sua volontà, i decreti portano il
suo stile diretto e decisionista, le nomine rispecchiano le sue
strategie. I due consoli che lo accompagnano, pur autorevoli e
rispettati, appaiono più come consiglieri scelti che non come pari.
Cambacérès, con il suo aplomb giuridico e la profonda conoscenza
del diritto romano, svolge un ruolo essenziale nella definizione
normativa del regime. Lebrun, d’altra parte, fornisce il
trait-d’union con il passato monarchico e l’amministrazione
pre-rivoluzionaria, rassicurando le classi proprietarie ancora
incerte.
Ma è Bonaparte, e solo lui, a irradiare potere. Durante la
cerimonia, ha parlato poco, ma ogni sguardo rivolto a lui dai
presidenti testimoniava una reverenza che andava oltre il rispetto
costituzionale. Più che un amministratore, più che un legislatore,
egli appare come il garante della sopravvivenza della Repubblica
stessa. Una figura mitica, per certi versi. Il generale che aveva
vinto le armate d’Austria e d’Egitto, che aveva domato l’anarchia
parigina senza spargimenti di sangue, ora guida la nazione con mano
ferma, ma senza (ancora) la corona.
Molti osservatori stranieri, e alcuni attenti intellettuali
francesi, cominciano già a domandarsi se questo nuovo Consolato non
sia altro che una monarchia mascherata. Il potere concentrato nelle
mani di un solo uomo, la subordinazione delle camere legislative, il
controllo della stampa, la riorganizzazione delle amministrazioni
locali su base nominativa anziché elettiva: tutti segnali che, presi
insieme, delineano una progressiva verticalizzazione del potere.
Eppure, per ora, tutto ciò appare funzionale alla ricostruzione del
Paese.
Dopo anni di disordine, dopo il Terrore e le guerre civili, dopo
la bancarotta e l’insicurezza costante, la Francia sembra disposta
a sacrificare parte della sua libertà per ottenere stabilità.
“Meglio un padrone che il caos,” ha dichiarato un mercante della
Rue Saint-Honoré, sintetizzando in una frase il sentimento diffuso
tra le classi produttive e borghesi.
I presidenti che hanno giurato fedeltà oggi rappresentano, almeno
sulla carta, le garanzie della legalità costituzionale. Il Tribunato
discute le leggi, il Corpo Legislativo le approva, il Senato ne
garantisce la conformità ai principi costituzionali. Ma è il
Consiglio di Stato — presieduto direttamente da Bonaparte — a
elaborare i testi legislativi, in un meccanismo che rafforza
ulteriormente l'esecutivo.
Gli uomini scelti per queste cariche sono perlopiù moderati,
repubblicani tiepidi, tecnocrati illuminati. Sono stati selezionati
più per la loro competenza che per la loro adesione ideologica a una
linea politica. In questo, il Consolato mostra una fisionomia nuova:
una repubblica di funzionari, piuttosto che una repubblica di
tribuni.
La Francia del Consolato, così com’è emersa dalla cerimonia di
giuramento, si presenta come una Repubblica riformata e
centralizzata, ma ancora ufficialmente fedele ai princìpi del 1789.
Non si proclama la monarchia, non si parla di impero, eppure lo
spettro del potere personale aleggia, visibile ma ancora tacito.
Nessuno oggi, tra i presidenti che hanno giurato, può davvero
sapere se il futuro riserverà nuove libertà o un nuovo trono. Ma in
questa giornata storica, in cui il destino della Repubblica si è
fuso con la volontà di un solo uomo, la Francia ha compiuto un passo
decisivo. Non verso il passato, non ancora verso l’autocrazia, ma
certamente verso una nuova concezione del potere: non più
espressione delle piazze, ma strumento dell’efficienza.
Il giuramento dei presidenti davanti ai tre consoli non è solo
una formalità: è l’atto di nascita di un’epoca in cui il
governo sarà più tecnico che politico, più stabile che
rappresentativo, più pragmatico che ideologico. Un'epoca che porta
già un nome: l'era bonapartista.